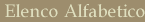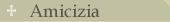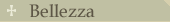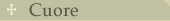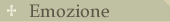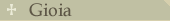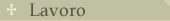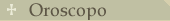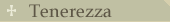Bibbia a fumetti - Castigat ridendo mores - da Astrologia a Vita Sociale il dizionario dei problemi dell'uomo moderno
Emanuele
Samek Lodovici
una conferenza inedita
L' arte di non disperare
Il 5 maggio 1981
Emanuele Samek Lodovici
moriva per i postumi di un incidente stradale. Era uno del
collaboratori più apprezzati di Studi cattolici, e il suo
entusiasmo, la sua intelligenza, la sua generosità hanno lasciato una traccia
incancellabile. Lo ricordiamo, a vent'anni da quel
triste giorno, con la pubblicazione di una conferenza inedita, pronunciata nel
maggio del 1980 e trascritta a cura del suo allieva
torinese Gianluca Segre. La conferenza era rivolta
ai genitori degli studenti di un centro scolastico: per questo, nella parte
finale, i temi familiari vengono in primo piano.
Cercherò, nel dire ciò che intendo dire, di essere utile. Comincerò allora col mostrare quali sono
alcuni motivi di disperazione: naturalmente non farò altro che delle
dichiarazioni di voto, pronuncerò dei giudici tranchants,
che non è possibile documentare in una conversazione come questa.
Una prima dichiarazione è il mio giudizio
sul `68. Che cosa è avvenuto? Per parlarne occorre
anzitutto ricordare che noi viviamo da tre secoli
all’interno di quello che definisco come attacco macrostrutturale
ai valori, ai valori che sono radicati e personificati nella tradizione
occidentale cristiana. Dall'Illuminismo in poi si è
sviluppata una critica frontale nei confronti del cristianesimo e dei valori a esso collegati, e che sono anche valori «laici» con una
matrice cristiana.
Chiamo questo tipo di attacco
«macrostrutturale», di grande struttura, poiché muove
contro il cristianesimo, per così
dire, sul piano speculativo: è un conflitto tra idee e visioni del mondo.
Un esempio evidente è rappresentato dal
marxismo, il quale attacca il cristianesimo e i valori tradizionali con la
tesi, a tutti nota, che i valori altro non sono che
l'espressione di una struttura economica. Invece per la concezione cristiana e
per le visioni del mondo a essa collegate, per esempio
nelle morali che si rifanno a Kant, parlare di
spirito, di anima, non significa riferirsi a una realtà determinata dalla
struttura sociale. È significativa l’affermazione di
Marx secondo cui non è la coscienza che determina la struttura sociale, ma è
la struttura sociale che determina la coscienza umana.
Sino al `68, in linea di massima, ci
siamo trovati di fronte a una lunga parabola di
sistemi che si sono passati via via la palla nel
tentativo di colpire il cristianesimo sul piano dei princìpi,
onde screditare la credibilità dei principi stessi, quali l'immortalità
dell'anima, l'esistenza del peccato originale, la condizione dell’ uomo come
essere finito e limitato, e così via.
Un nuovo senso comune
Ed ecco un'altra dichiarazione di voto: a partire dal '
La differenza tra i due tipi di attacco va sottolineata: un conto è la discussione con
un'altra persona a livello teorico, sul piano della validità o meno delle
rispettive posizioni; altro è far sì che l'antagonista venga condotto a vivere,
nella pratica, come se non credesse ai principi che sostiene.
La filosofia dei corpo
Ne vogliamo qualche esempio? Prendiamo
quel fenomeno che abbiamo ogni giorno di fronte e che possiamo recepire attraverso le edicole: è ciò che chiamo la
«filosofia del corpo». Basta un minimo di sensibilità per chiederci che cosa si
nasconde dietro alla nudità indiscreta, procace e violenta che giunge da
televisioni e giornali. Cerchiamo di leggere oltre e oltre e osserviamo che
cosa significa quell'immagine sempre vistosa, sempre perfetta, sempre igienicamente integra del
corpo femminile, e tra non molto maschile, e che a me sembra sempre più
infetta; dietro questa fiera delle vanità troviamo un'esaltazione del corpo
inteso come vita, vita incorruttibile, che è perfetta e non conosce la morte,
che è sempre all'apice del ciclo biologico. Questa esaltazione del corpo come
vita, ottenuta tramite la nudità ostentata, si presenta nel mondo contemporaneo
con numerose modalità, tutte rivolte a negare la corrutibilità
del corpo stesso.
Basti pensare ai fenomeni di protesi e di ricostruzione del corpo, dalla parrucca messa sulla calvizie alle iniezioni di silicone nel seno, ai tacchi alti, alla plastica facciale: ci troviamo di fronte all'affermazione che il corpo non può morire, non può contrarsi, non può iniziare la fase declinante del ciclo, e che può in ogni momento essere restaurato tramite la protesi.
Un'altra manifestazione di questa
filosofia del corpo è la droga. Non mi riferisco alla
banalità di quelle inimitabili figure sulla droga che «fa tanto male», ma al
suo significato filosofico, di cui anche i fautori e difensori della droga non
sono necessariamente coscienti. La droga è
stimolazione della potenza del corpo, e il corpo è
vita che c'è, vita che non muore, vita che deve essere in grado di dare a sé
stessa un'infinita di sensazioni; la droga esalta il corpo come un valore che
non può perire.
Nel senso comune questa manifestazione
della vitalità si tramuta immediatamente in senso anticristiano, cioè nel rifiuto della finitezza; si esalta il corpo come
qualcosa di infinito negando così la nostra inevitabile condizione creaturale, di esseri finiti.
Il principio del piacere
Il tentativo di istituire un nuovo senso comune colpisce anche il criterio ispiratore delle nostre scelte, sostituendo il principio di responsabilità con il princìpio del piacere. Pensiamo ai messaggi nascosti che ogni giorno ci arrivano. Perché essere fedeli? Perché non sfruttare la nostra occasione per correre la cavallina? Perché alzarsi di notte per un figlio che piange?. Perché cedere il posto in treno a un anziano? Chi te lo fa fare? Perché stare con i bambini piuttosto che leggere il giornale o piazzarsi davanti alla televisione? Perché scegliere per te il cibo meno interessante tra quelli che sono in tavola? Progressivamente, e in modo del tutto insensibile, ci viene trasmesso un messaggio di estrema precisione: nelle me scelte ricorda che quello che conta è il principio del piacere; nelle tue scelte ricordati che devi goderti la vita a qualunque costo, dove «a qualunque costo» vuol dire sempre a costo di qualcun altro.
Un ulteriore
esempio è dato dal caso della donna. Intendo con ciò il processo attraverso il
quale la donna viene progressivamente portata a pensarsi
come un essere che non ha legami nei confronti di alcunché, che non è
responsabile nei confronti di nulla; parlo evidentemente di quel fenomeno
banale, ma profondo nella sua banalità, che è il femminismo.
Che cosa
significa responsabilità? Vuol dire essere sponsus
rebus, sposato alla realtà, legato al mio dovere: in questo caso, parlando
della donna. se è maritata, legata alla famiglia.
Quando prevale un'immagine della donna slegata, tendenzialmente
maschile, capace di una sessualità nomade, di una mobilità di
carriera, è chiaro che si è progressivamente costruita l’immagine di una donna
che al posto di trasmettere valori ai fìgli,
trasmette la propria volontà incerta. Naturalmente questo discorso vale anche
per l'uomo, che non ha alcun privilegio rispetto alla donna; tuttavia, è bene
riflettere su quanto incide questa derealizzazione,
questa deresponsabilizzazione
della donna nei suoi effetti sulla famiglia.
Gli esempi riferiti documentami
la tesi iniziale: si sta instaurando un nuovo senso comune che rende invivibile la tradizione, anche quand'essa rimane un valore
sul piano della convinzione intellettuale. Ecco il risultato dell'attacco
microstrutturale, che riguarda il modo di vivere i princìpi:
e noi sappiamo che, a forza di non agire come
pensiamo, finiamo per pensare come agiamo. E’ inutile difendere in modo
retorico i valori se li contraddiciamo sul piano
della prassi: a questo punto occorre reagire.
L'inizio della speranza
Così stando le cose, come proporre
un'inversione dì tendenza? Non c'è flusso che non si possa,
volendo, trasformare in riflusso: ci viene in soccorsa l'arte di non disperare.
Ma come si impara? Naturalmente, mi spiace dirlo, se è
un'arte non s'impara. Questo è un aspetto importante,
che ci può illuminare: per imparare a non disperare non possediamo tecniche.
Questo capita con tutte le arti; ognuno sa che in una bottega d'arte avviene
di fatto caratteristico: da una parte c'è il maestro,
e dall’altra il discepolo; il maestro può insegnare varie cose al discepolo,
per esempio la tecnica della prospettiva, o del miscelamento
dei colori: ma non può insegnargli a essere un'artista.
Allo stesso modo noi non siamo in grado di «produrre» la speranza. Con questo voglio ricordare un dato fondamentale della tradizione cristiana, secondo cui il momento iniziale di tutte le cose non dipende da noi. Per esempio, io non sono in grado di produrre in me la fede: c'è qualcos’altro che mi rende capace di avere fede, e teologicamente si chiama grazia. Ora, passando dal piano teologico a quello naturale, posso con estrema facilità dire che in tutto quello che ci interessa vi è un elemento iniziale, un primo passo è il primo passo che conta, quello che vince l'attrito, non dipendente da noi. Allora per iniziare a sperare non basta voler sperare, poiché questo dipende dalla grazia, dalla virtù teologale il cui appello iniziale non tocca a noi. Quindi l'arte di non disperare non s'impara; ma dire non s'impara non vuol dire che non c'è, vuol dire che la dobbiamo desiderare; dobbiamo desiderare che ci cada addosso, incominciando in senso forte a sperare.
Per usare le parole di san Paolo dobbiamo
cominciare ad avere una spes
contra spem, alla
speranza contro tutte le speranze mondane. Dunque, l'arte di non disperare
nel suo inizio non dipende da noi, ma quando è iniziata
dipende poi tutta da noi. Questo è l'aspetto paradossale: non sono in grado di
produrre in me la fede, ma quando la possiedo la devo esercitare. Non sono in
grado di produrre la speranza, ma quando ce l'ho non
devo solo dire “io spero”, ma fare come i bravi sportivi, cioè esercitare la
speranza, fare tutte le volle, diceva il catechismo, l'atto di speranza, e
riflettere sul suo contenuto. Come diceva mons. Escrivà,
«Dio non perde battaglie». Se un vero atleta si
esercita tutti i giorni, noi, per esercitarci a essere
uomini tutti i giorni, dobbiamo fortificarci nella speranza.
La Provvidenza
L'esercizio della speranza ci fa capire
che qualunque cosa accada, per noi andrà a finire bene. Attenzione: siamo
abituati a pensare la provvidenza in un modo banale, nel senso che “ci vada a
finire bene». Chi non ha presente I Promessi Sposi? In questo romanzo
grande, bello, ironico, sembra apparire un concetto di speranza alquanto diverso:
A ama B, C impedisce l'amore di A con B, inizia la
storia e, in conclusione, C finisce al lazzaretto, mentre A e B concludono il
loro sogno di amore. Questa è l'immagine della provvidenza in cui “a noi
finisce bene”. Anch’io dico che a noi finisce bene,
ma in modo diverso. Qualunque cosa accada, ecco la
speranza che dobbiamo esercitare, dobbiamo sperare di finire bene nel senso
di diventare migliori. Con Platone possiamo dire: per te è meglio subire
ingiustizia piuttosto che farla; questo è il grande
senso della giustizia.
Tutto quello che conta è che tu finisca migliore. Un grandissimo uomo di speranza, Aleksandr Solzenicyn, direbbe: “Che tu esca dalla vita meglio di quando vi sei entrato”. È certo che qualunque cosa accada, che vada finire bene o male in senso naturale, a noi andrà a finir meglio. Dobbiamo desiderare di diventare migliori; questa è la speranza umana più vicina alla speranza teologale: che noi si esca migliori da questa vita.
II vero
combattimento
La terza regola
dell'arte di non disperare si vede dagli effetti. Chi spera combatte.
Il combattere è fondamentale per l'uomo che spera, ma come? Da una poesia di T. S. Eliot emerge la regola del
vero combattente, la regola di chi compie l'azione
sperando; dice Eliot (nei Dry Salvages
dei Quattro Quartetti tradotti da Filippo Donini):
Quando il treno parte, e i passeggeri sono a
posto,
intenti
alla frutta, ai periodici e alle lettere d’affari
(e quelli
ch’eran venuti a salutarli se ne sono andati via
dal
marciapiede)
i loro volti si spianano dal dolore al sollievo,
al ritmo sonnacchioso di un centinaio d'ore.
Avanti
viaggiatori! Senza sfuggire dal passato
a vite differenti o a qualsiasi futuro;
non siete la stessa gente che ha lasciato la stazione
o che arriverà a una destinazione qualsiasi,
mentre i binari sfuggenti si stringono dietro di voi;
e sul ponte del transatlantico possente
mentre guardate il solco che s’apre dietro di voi,
non dovere pensare che “il passato è finito”
o che il futuro è davanti a noi”.
(…)
Avanti, o voi che credete di
viaggiare;
non siete
voi quelli che videro il porto
allontanarsi, né quelli che sbarcheranno.
Nessuno di noi sbarcherà, nessuno di
noi vedrà il risultato
dell'azione
che veramente gli interessa.
Qui tra la sponda di qua e quella
lontana,
mentre il
tempo è sospeso, considerate il futuro
e il passato
con mente imparziale.
Nel momento che non è d’azione né d’inazione
Potete accogliere questo: “in qualunque sfera dell’essere
la
mente di un uomo possa essere intenta
al tempo
della morte” – ecco l’unica azione
(e il tempo della
morte è ogni momento)
che darà
frutto nella vita degli altri:
e non
pensate al frutto dell’azione.
Ecco
l'unica azione: se volete davvero agire voi che comunque
non sbarcherete, agite disinteressatamente, agite senza pensare ai risultati.
La vera azione è l'azione disinteressala anche se noi
non ne vedremo l'esito.
Io non so fino a che punto posso essere
maestro di coloro che mi ascoltano, ammesso che sia in grado di
essere maestro di qualcuno, ma questo è ciò che davvero conta per me:
non interessarmi ai frutti, ma interessarmi alla generosità del momento in cui
do; perché se diamo in considerazione dei frutti che otteniamo, diamo sempre
meno, combattiamo sempre meno. L'arte di non disperare si esprime così come
l'arte di combattere indipendentemente dal risultato.
Coloro che sul piano spirituale sono proletari combattono solo se sono sicuri
di vincere, quelli che sul piano spirituale sono borghesi combattono solo se
hanno qualcosa da conservare, quelli che sul piano spirituale sono nobili
combattono anche quando sono sicuri di perdere e proprio per questo vincono.
Una persona che si esercita a lottare
inizia poi anche a sperare. Fai come se non dovessi mai vedere la terra
promessa, fai come se non dovessi mai vedere ciò che sempre hai desiderato
vedere, e proprio per questo è probabile che tu la veda. Mai però lasciare il
combattimento, non solo verso un ipotetico avversario, ma il combattimento
vero, quello contro noi stessi per divenire migliori; riformiamo noi stessi per formare gli altri
Dilatare il cuore
Appartiene all'arte di non disperare
anche un quarto aspetto, quello che ci porta a non essere meschini, ad
allargare il cuore, a vedere anche le piccole cose nella
prospettiva delle grandi. Noi facciamo un edificio con modesti mattoni, ma è
importante sapere che dietro ai mattoni che ognuno porta si innalza
il grande edificio che amiamo. Una parabola proveniente dall'ebraismo
orientale esprime in modo significativo la
dilatazione del cuore del vero combattente.
C'è una persona che, passando per strada,
vede tre uomini intenti a costruire un muro; ognuno di loro compie esattamente
lo stesso gesto, l'impasto della calce. Il viandante chiede
al primo: “Che cosa stai facendo?” E l'altro: “Perché mi secchi, non vedi che
sono come uno schiavo alla ruota? Sto lavorando”. Il viandante rivolge
la stessa domanda al secondo, che risponde: “Ma
insomma, non vedi? Sto facendo un muretto. un muro
come un altro, tutti lo sanno fare”. Infine il viandante si rivolge al terzo
uomo; e l'altro, che sta facendo esattamente la stessa cosa dei primi due, con la
gioia sul volto risponde: “Non lo vedi? Sto costruendo il tempio, il tempio di Dio”.
Famiglia &
gratuità
Arte che non s'impara,
virtù che si esercita, speranza che si esprime nel combattimento, cuore che si
dilata; possiamo aggiungere un quinto e ultimo aspetto, la visione positiva.
Per non disperare occorre guardare, come tutti sanno,
la parte piena della bottiglia. E questa parte è
fatta dagli elementi che nella nostra esperienza sono buoni; da questi occorre
partire per il riflusso. Per non disperare occorre porre il piede su ciò che
c’è ed è valido; e se c’è qualcosa che già esiste e che è un grande elemento di
riflusso per ricostruire, contrastando il nuovo senso comune depravato, questa
è la famiglia.
Sia chiaro che non parlo
della patologia, ma della fisiologia, del buon funzionamento della famiglia,
di ciò che essa è o può essere per propria natura. Se essa è il luogo centrale
dell'educazione, quale ne è l'elemento centrale? È la
famiglia come luogo della gratuità, in cui si è accettati indipendentemente
dalla funzione che potremmo svolgere. Sappiamo che nella vita quotidiana siamo
accettati, fuori dalla famiglia, nella misura in cui
svolgiamo una funzione e quindi rientriamo in un meccanismo, per esempio
l'ambiente di un ospedale, di un tribunale, di un ufficio; siamo accettati se
davvero svolgiamo quel determinato compito; non avviene mai che all'interno di
una banca un impiegato venga accettato se non adempie la sua funzione. I
rapporti fuori della famiglia sono rapporti bronzei,
di prestazione si usa dire, ma nella famiglia non si è accettati per le
prestazioni che si danno, ma per quello che si è. Ecco l'aspetto gratuito,
spontaneo, non funzionale della famiglia. Il figlio è accettato per quello che
è, non perché porta del denaro o svolge una mansione, e così è per il marito,
così per la moglie; il primo aspetto essenziale di una famiglia è: ti accetto
per quello che sei.
Secondo aspetto: proprio perché ti accetto per quello che sei e non per la funzione che svolgi, la famiglia è il luogo della permanenza. È quindi luogo della fiducia: siccome ti accetto per ciò che sei, vuol dire che ti accetto permanentemente; questo permette di esercitare la virtù della fiducia e dell'altruismo, in quanto ognuno sa di essere accettato, nonostante tutto quello che di fatto possa essere. La famiglia diviene così anche luogo della sincerità, nel quale non ho bisogno, come inevitabilmente avviene all'esterno, di assumere una sorta dì presentabilità; vediamo le persone per quello che sono e ci abituiamo a presentarci per quello che siamo, a essere sinceri. Non c'è spazio per la doppiezza perché non avrebbe senso mascherarsi. Se sono accettato per quello che sono, mi abituo a essere sincero e, cosa importante, imparo a vedere gli altri per quello che sono, e quindi acquisto il senso della realtà.
Terzo aspetto: la
famiglia come luogo delle virtù possibili, e non solo di quelle funzionali.
Nel mondo del lavoro la virtù della laboriosità è richiesta, poiché debbono esserci dei risultati; ma il mondo esterno alla
famiglia ben di rado spinge a sviluppare altre virtù, assolutamente
importanti, che sono il perno della famiglia stessa: per esempio la generosità.
È una tipica virtù che si origina nella famiglia, dove i rapporti non sono di
prestazioni reciproche; il padre che ama un figlio, il fratello che ama il fratello, lo fanno indipendentemente dal reciproco do
ut des, lo fanno in sovrappiù. Perché?
In quel rapporto che sin da principio si è instaurato, un rapporto sincero tra
persone che si conoscono per quel che sono, la generosità diventa un fatto
naturale, e così il sacrificio. Notiamo bene che un tal modo di formarsi è
fondamentale, perché chi ne esce fuori è un uomo e
non un uomo dimezzato.
Lo stile, non il risultato
La grandezza dell'arte di non disperare
ci ha portato a considerare gli elementi dai quali avviare la ricostru-zione.
Come abbiamo visto, la famiglia è il luogo dove con naturalezza si possono
vivere valori eminenti come la gratuità, come la sincerità, e
dove nasce un certo «stile di vita». Quando la
famiglia è il luogo dove le persone sono accolte per quello che sono, allora si
può far sì che i figli crescano con questo principio: che nella vita non
importa mai il risultato, ma il come. Uno dei punti essenziali che la
tradizione cristiana ha trasmesso è questo: noi siamo come in un grande teatro, il teatro del mondo, e in esso si svolge la
scena e la recita della nostra vita; da un momento all'altro questa scena può
essere sbaraccata. A chiunque di noi può capitare che il fondale venga arrotolato e si dica: è finito. Siccome tu sei in
questa scena e vi svolgi una parte, allora la cosa
più importante non è il ruolo che svolgi, ma come lo svolgi. Non importa che tu
in scena sia il re piuttosto che lo schiavo, il
domestico piuttosto che l'ingegnere o il medico. Tu devi tener fermo, se sei
sapiente. che il teatro del mondo da un momento
all'altro viene arrotolato. Allora la cosa migliore che ti deve essere
insegnata è che nella vita più che il risultato conta il come; più che il fine
importa lo stile. Se ci pensiamo, è proprio ciò che
oggi si è perso di vista.
Si ritiene che la vita sia giustificata sulla base dei risultati ottenuti: far carriera, diventare grandi docenti universitari, grandi giuristi, ingegneri, notai. È chiaro che questo è l'aspetto più logorante poiché, da un altro punto di vista, nella vita quanto ai risultati siamo sempre truffati, il teatro viene sempre arrotolato. E sappiamo che, se c'è una malattia diffusa nel nostro mondo, è la nevrosi determinata da questa obbligatorietà al successo; chi non raggiunge il successo si dice obbligatoriamente un fallito. Non è affatto così che dobbiamo pensare. Una famiglia che funzioni deve educare i suoi figli dicendo a ciascuno di loro: ricordati che quello che conta non sono i risultati ma il come; se hai capito questo verranno anche i risultati, se non lo hai capito anche i risultati che verranno non potranno essere da te compresi. Se ci rendiamo conto di come può essere la famiglia, di come può costruire uomini diversi, con un senso comune diverso da quello di cui parlavo prima, noi abbiamo avverato l'ultima regola del non disperare.
Diversamente, se vogliamo fare che i
nostri figli siano come gli altri, allora saranno tutti come tante formichine:
e ricordiamo che per le formiche ci sono due soluzioni, o l’entomologo o il
formichiere.
Considerazioni
inattuali
Alla luce di quanto detto, si impongono alcune considerazioni. Perché
il compito educativo del genitore è così insostituibile? Perché, per esempio,
è più importante fare un uomo che non fare un libro;
una volta letto, il libro viene chiuso, ma quando un uomo è stato fatto parla
per tutta la vita.
Un secondo aspetto riguarda
l'accettazione. Accettare un figlio non vuol certamente dire non correggerlo, ma accettarlo per quello che è, con quella natura, con
quel tipo di intelligenza. Accettare non vuol dire lasciare che un figlio
faccia quello che vuole, poiché questo non è liberarlo, è
anzi lasciarlo in balia di pseudoscelte che lo
rendono schiavo di ciò che in quel momento sulla piazza ha la voce più forte.
Accettare non vuol dire neppure volere che nostro figlio sia, poniamo, quella persona così capace che avremmo desiderato, o volere che faccia ciò che facciamo noi: vuol dire progressivamente portarlo a fare delle scelte libere. Essere educati significa essere condotti alla libertà. Tanti padri, tante madri «rovinano», tra virgolette, perché pensano che sia meglio, in modo più o meno occulto, far sì che il figlio faccia come loro. L'autorità dei genitori non può essere stupida, deve essere intelligente, un'autorità «autorevole» come avviene nelle botteghe artigianali, dove non si insegna direttamente, ma con l'esempio. Se vogliamo che i figli ci amino, non dobbiamo parlare di amore, ma dobbiamo amare; se vogliamo che siano sinceri. dobbiamo essere sinceri. Diversamente, le parole assumono un tono fatuo, come “i grandi valori”, “la verità”, e così via.
Un terzo aspetto riguarda la fortezza. Di
fronte all'obiezione per cui.
agendo con tali princìpi, i
figli diverrebbero dei disadattati, ritengo che non inserire i figli in questa
società sia un dovere. Occorre abituarli a dire no al predominio dei cretini,
abituarli in fondo a capire, come paradosso, che devono essere intelligenti
perché soltanto loro capiranno perché gli stupidi fanno carriera. Bisogna insegnare
ai figli a fare fronte, a resistere e ad assalire, cioè
a essere forti, poiché se sono farti cambiano l'ambiente; certo costa, ma nei
tempi lunghi darà grandi frutti. Non dobbiamo perciò preoccuparci se
trasmettendo uno stile di vita ne facciamo dei disadattati; non bisogna cedere
prima degli altri, se si sa perché si combatte. Un filosofo
che amo, Nietzsche, afferma: chi ha un perché
sopporta molti come. Pensiamoci; chi ha un perché nella vita sopporta
anche molte anormalità, molte delusioni iniziali, ma
assicuro che in ultimo la fine dei Proci la fanno gli altri.
Noi genitori abbiamo un capitale che sono i figli; dedicarsi a loro, impegnarsi magari a
collaborare a iniziative comuni, alla realizzazione di ambienti educativi, sarà
il nostro modo di portare il mattone per il tempio. Ecco la realtà meravigliosa
per un genitore, capire questo, che sta facendo il tempio, non una festa
aziendale o campestre; sta combattendo la nuova battaglia e allora inizia a
dilatare il cuore e a capire perché non si può più disperare.
Emanuele Samek Lodovici
Da Studi Cattolici, Ares
- Milano
Maggio 2001